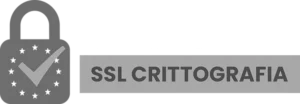Il Corsaro, l’avventura corre in orchestra al Teatro Carlo Felice di Genova.
Il Corsaro: un’opera che fin dalla gestazione navigò in acque tempestose, in un periodo molto intenso sia per il giovane Verdi (i suoi “anni di galera”, di stress e superlavoro, diremmo oggi) che per l’Europa, nel 1848 dei moti rivoluzionari. Emanuele Muzio, allievo dell’autore, avrebbe dovuto essere sul podio al suo posto, poiché Verdi si trovava a Parigi; dopo il ritorno a Milano degli Austriaci, però, egli fuggì in esilio in Svizzera, lasciando a dirigere Giuseppe Scaramelli. Per il Corsaro ci furono soltanto tre recite dopo l’esordio, il 25 ottobre 1848, quindi lunghi silenzi e riprese “a singhiozzo”, di cui l’editore Francesco Lucca aveva incolpato lo stesso Verdi, non particolarmente interessato alle sorti di questo lavoro. Eppure si tratta di un’opera interessante, con alcuni manierismi, forse, ma, per citare Mario Medici, “la materia è compatta, vibrante, l’accento inconfondibile, il taglio netto”, con una grande mobilità ed instabilità dei giri armonici fin dal preludio d’apertura che anticipa i temi principali, indice della ricerca, dell’urgenza di scandagliare, scavare, raggiungere il massimo dell’espressione col minimo spreco.
La vicenda, tratta dal racconto in versi The Corsair di George Byron, ci mostra un protagonista dai tratti fortemente romantici: il corsaro Corrado, costretto alla vita errabonda da una sorte avversa e misteriosa, ma nostalgico dei tempi in cui poteva vivere una vita onesta e serena (“Tutto parea sorridere”, Atto I). Un po’ eroe maledetto, un po’ anarchico, con un forte senso dell’onore e non privo di ideali generosi: il pensiero corre immediatamente a Carlo dei Masnadieri, opera che Verdi aveva completato poco prima per Londra. I due personaggi si somigliano, e vi è una citazione della cabaletta di Carlo nella sezione “All’armi, all’armi!” nel primo atto del Corsaro. Le due protagoniste femminili, Medora, amante di Corrado, e Gulnara, favorita del pascià nemico Seid, non potrebbero essere più diverse: languida ed infelice la prima, logorata dalle lunghe assenze del Corsaro, volitiva e risoluta la seconda, ben decisa a spezzare le catene fatte di seta e perle che la imprigionano nell’harem. Il pascià è tutt’altro che indolente: uomo d’armi, in prima linea con i suoi soldati, fa sfoggio di una perfidia di maniera che non è esente da una certa ispirazione, musicalmente si fa strada qui il Verdi più “militare”: in effetti – a ben guardare! – i turchi vogliono sbarazzarsi dei pirati che infestano il mare non per crudeltà, ma per rendere più sicura la navigazione…
L’intreccio fra le ragioni della guerra e quelle, ben più complesse, del cuore non può mancare: Gulnara deve la vita a Corrado – il quale, cavallerescamente, ha sacrificato il buon esito della battaglia per salvare le odalische da un incendio – e, immancabilmente, se ne innamora, arrivando ad uccidere di sua mano il pascià per salvarlo; il Corsaro resta (ci piace pensare) fedele a Medora, ma non può non aggrapparsi ad uno spiraglio di luce nella tetra prigione in cui è incatenato. Il pascià, dal canto suo, più che per la rivalità di bandiera odia visceralmente Corrado per il sentimento che ha suscitato nella sua favorita, della quale avverte il disprezzo; nel terzo atto, il suo cupo recitativo “della gelosia” introduce l’Allegro maestoso “S’avvicina il tuo momento”, in cui, ben sostenuto dall’orchestra che danza ritmi di morte, si abbandona quasi istericamente ai propositi di vendetta. Il duetto con Gulnara, teso a svelare i sentimenti colpevoli di lei, anticipa l’indagine psicologicamente incalzante di Amneris ad Aida, e i due differenti piani del sentire si compenetrano, sotterranei eppure rivelatori, nel tortuoso e sfuggente accompagnamento musicale.
Il “cattivo” trova la morte sulla punta del coltello di Gulnara, una scena cui – com’è consuetudine nel teatro di quest’epoca – non assistiamo, ma che viene evocata per noi dall’orchestra che disegna folate impetuose, tuoni e marosi: la bufera che imperversa in mare è specchio e nemesi di quella che agita le anime di Corrado e Gulnara, ormai uniti da un destino di sangue. Macbeth e Rigoletto, ça va sans dire: Verdi sperimenta qui un connubio, assassinio e notte di tempesta, che sarà cifra di alcuni dei suoi momenti più musicalmente e drammaturgicamente efficaci.
Uno happy end, in un’opera romantica, non è contemplato: Corrado non giunge in tempo da Medora, che sta morendo di dolore (aiutata da una dose di veleno racchiusa in un anello fatale!). Se nel poemetto di Byron Medora è già spirata all’arrivo del Corsaro, qui il librettista Francesco Maria Piave sceglie una narrazione diversa, con il confronto, vagamente donizettiano e non senza qualche imbarazzo, dell’insolito terzetto: Medora spira tra le braccia dell’amato dopo aver ringraziato la generosità di Gulnara, la quale non trova di meglio che confessare alla morente il proprio amore colpevole per Corrado. Tempismo non proprio perfetto, insomma, per togliere a Medora la possibilità di morire in pace; musicalmente Verdi risolve la situazione con uno dei “suoi” concertati, molto Trovatore-style, che compone i contrasti irrisolti di una trama drammaturgicamente debole, in cui si intrecciano il sacrificio inutile di Gulnara, il suicidio affrettato di Medora, la rassegnazione testarda ad aderire ad un destino infelice di Corrado.
Sì, perché la musica è il vero punto di forza di quest’opera “diversamente verdiana”, minore soltanto all’apparenza: la concertazione di Renato Palumbo, insieme con la sua direzione vivissima, danzante, intensa, rivela le trame più nascoste di un discorso musicale teso, rapido, incalzante, facendosi sospiro e dolore di Medora, azione guerresca e disperazione di Corrado, sensualità ed audacia di Gulnara, baldanza e ferocia (con una punta di vulnerabilità) di Seid.
Se la narrazione è piuttosto esile, per non dire che non succede praticamente nulla, la varietà dei cosiddetti “pezzi chiusi” di un’opera ancora legata alla tradizione dei “numeri” mostra un’invenzione melodica e timbrica di Verdi fortemente evocativa, ricca e piena di spunti, c’è la burrasca che sarà di Otello e ci sono gli slanci che animeranno Traviata, ascoltiamo echi che provengono dai Due Foscari e dal rossiniano Guillaume Tell, ma anche tenerezze che ritroveremo a breve in Luisa Miller. Palumbo, insomma, tiene saldamente il timone della nave del Corsaro genovese: uno sviluppo motivico ricco e denso, una trasparenza nelle linee degli archi e nei sospiri sommessi dei fiati che trova immediatamente il contrasto del fragore della piena orchestra, punteggiata di ottoni battaglieri e percussioni ostinate, nelle scene di guerra.
A proposito di guerra: menzione speciale per Renzo Musumeci Greco, maestro d’armi, che ha lavorato alle coreografie delle battaglie. I suoi duelli fra corsari e musulmani arrivavano direttamente da un film di cappa e spada, visivamente molto cinematografici: tra affondi di fioretto e sciabolate di scimitarra le due schiere nemiche si muovevano disinvolte in una danza mortale priva di qualsiasi goffaggine o manierismo da finzione scenica, spesso sospesa tra le sartie e gli alberi dell’imbarcazione che è teatro e fulcro dell’azione.
La regia di Lamberto Puggelli (ripresa qui da Pier Paolo Zoni, con le belle scene di Marco Capuana) fa del mare il grande, vivo, multiforme protagonista: l’intera opera si svolge sulla tolda di una nave, le vele nere dei corsari, rosso sangue dei musulmani, bianche dell’harem sono il riflesso delle emozioni che scorrono, velocissime e potenti, in scena. L’orizzonte si tinge dei colori della notte di luna piena più dolce, che fa da sfondo alla veglia di Medora, o del bagliore sinistro dell’incendio durante la battaglia, o ancora del nero più cupo e disperato, solcato dalle folgori, che racconta la prigionia di Corrado. Una lettura efficacissima anche nel finale, con la lunghissima scala protesa verso il nulla, metafora di una morte mai esplicitamente suggerita che potrebbe essere, magari, la fuga in mondi lontani, dove la violenza degli uomini non è ancora arrivata.
Un cast scintillante ha animato le navi corsare tanto quanto le avversarie: tutti, nessuno escluso, hanno contribuito al successo di una rappresentazione più volte punteggiata (e per fortuna, direi, l’opera è anche questo!), dall’entusiasmo e dal calore dell’attentissimo pubblico.
Irina Lungu è una Medora delicata ed esangue, che fa il suo ingresso in scena come una pallida apparizione: nel primo atto la sua romanza “Non so le tetre immagini” si imprime nella memoria per la dolcezza del timbro, la sicurezza delle disperate fioriture finali, agili e cristalline, i filati perfetti, l’emissione fluente e senza spigoli. Nel finale racconta con espressività misurata il rimpianto del proprio personaggio, che troppo presto ed incautamente ha detto addio alla vita: nel commovente addio “O mio Corrado” la sua voce si fa un filo sottilissimo, eppure d’acciaio, senza perdere un millimetro di intonazione.
Sul versante opposto, Gulnara, la cui feroce determinazione è rappresentata da un melodizzare ampio, con esotismi nelle fioriture e dinamiche di grande espressività, che Olga Maslova restituisce in modo personalissimo: grande padronanza scenica, calore, ed un timbro generoso, scuro e duttile, in grado di piegarsi alle esigenze di una scrittura spesso non agevole; all’inizio costretta da una prigionia dorata, si erge a vera protagonista dopo la battaglia fra musulmani e corsari, quando la sete di libertà, unita all’innamoramento per Corrado, si fa strada nel personaggio, capace di passare dalla seduzione all’azione con uguale efficacia. Intenso ed avventuroso il duetto con il corsaro: Maslova affronta senza esitazioni i cromatismi e le ascese della prima parte, che culmina nei “Fuggiam!” ripetuti, fissi, ipnotici; nella stretta finale, dopo che ella ha compiuto il fatto di sangue, le due voci della favorita e del Corsaro si uniscono dando forza ed unità ad una scrittura forse un po’ troppo tradizionale, ma comunque efficace per comunicare l’intento drammatico. Per il giovane soprano russo una prova più che convincente, premiata dal pubblico con un omaggio finale intenso ed entusiastico.
Il Seid di Mario Cassi riesce a dare sfaccettature nuove ad un personaggio che, nella stesura della parte, risulta diversamente un po’ ieratico e con qualche punta di retorica, che pure Verdi non disdegnava di utilizzare per certi ritratti più “solidi”, meno mossi. Inizialmente statico, Cassi segue bene l’animarsi di Seid, vincitore in battaglia ma sconfitto in amore, e con timbro pieno e sicuro avvia con forza il concertato del I atto resistendo bene agli impeti del rivale. Ottima anche la resa del duetto-interrogatorio con Gulnara, quando l’orgoglio dell’amore non corrisposto e – forse – tradito traspare in tutta la propria crudele intenzione di vendetta (“Pensaci e trema!”, III)
Last but not least, Francesco Meli: il giovane e già affermato tenore “gioca in casa” nella sua Genova! Al primo apparire, appeso spavaldo alle sartie della nave pirata, si prende tutta la scena, e si ammanta dei panni dell’eroe maudit fin dalla cavatina “Tutto parea sorridere”: con morbidezza di timbro e ottima resa melodica tratteggia il contrasto del proprio personaggio, diviso tra la malinconia per un passato perduto il cui ricordo è dolcissimo ed un presente di azione e violenza. La parte finale, accompagnata dai pizzicati, apre all’eroico, e senza soluzione di continuità passa nella cabaletta che propizia la battaglia e, quindi, richiama “all’armi” i compagni, fondendosi con il coro, senza peraltro perdere il proprio ruolo di guida e catalizzatore dell’azione, scenica e non. Nel duetto con Medora il tenore genovese ed il soprano russo mostrano con efficacia l’incomunicabilità fra i personaggi, l’uno in corsa verso un destino che potrebbe benissimo evitare, l’altra chiusa in un sogno di sventura, due monologhi, che il sentimento – palpabile ed accorato – non basta a fondere in un dialogo.
Ma è nella scena e duetto della prigionia che Meli raggiunge le vette di questa interpretazione: “Eccomi prigioniero” (Atto III), introdotto da quartine quasi funebri, è il canto di un leone in gabbia, morente, ma non domo. Verdi qui è, al solito direi, maestro dei contrasti, viola e violoncello sono un mormorio sommesso che viene dal Guillaume Tell e disegna la solitudine del protagonista, più in pena per Medora che per se stesso; il recitativo-arioso è un momento – l’unico – in cui la parte del tenore è un canto spiegato, ben modulato e sostenuto da Meli nelle aperture, chiarissimo nelle mezze voci e nelle note più basse, agile e cristallino senza perdere di pathos e compostezza.
Applausi a scena aperta, nuovamente, ed un tributo finale giustamente lunghissimo e sentito.
Un bel mix tra racconto d’avventura, dunque, e romanzo romantico, con una spruzzata d’atmosfera da film di pirati, il Corsaro di Giuseppe Verdi è, in un forziere di gemme forse più scintillanti e “sfacciate”, una perla piccola ma preziosa, certamente meritevole di ritornare ad essere protagonista come lo è in questi giorni di recite a Genova, poiché brilla di sfumature proprie, intense, particolari e vivissime.